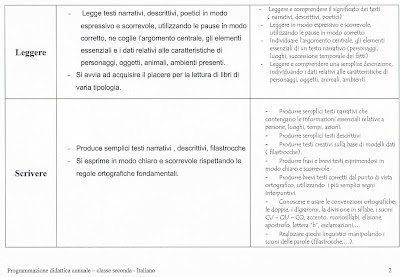Chi mi conosce o ha letto questo blog nel corso degli anni sa che prima di Michela Murgia è stata Anna (https://widepeak.wordpress.com) a farmi capire cosa significhi non considerare il cancro un nemico da combattere e quanto fosse rischioso l’uso delle metafore belliche, soprattutto quando la malattia avanza e le prospettive di guarigione si affievoliscono, fino a scomparire del tutto.
Anche grazie a lei ho modificato il titolo del mio libro, che inizialmente doveva essere Nella battaglia, perché così avevo taggato i post del mio racconto pubblico quando ho scoperto che il cancro al seno che credevo aver debellato aveva invece metastatizzato nel fegato.
Con il tempo, e anche grazie all’incontro con Anna, la metafora bellica ha iniziato a starmi stretta, e ne ho scelta un’altra, che incarnasse meglio la condizione di precarietà che si vive dopo una diagnosi di cancro. Mi sentivo più come una funambola che come una combattente.
Ho cercato di dare un senso a questo cambiamento di linguaggio anche raccontando le diverse esperienze di narrazione della malattia attraverso un blog in Scriverne fa bene. narrare la malattia, curarsi con un blog (Zona, 2012). In ogni storia l’uso delle parole che definiscono la malattia e le cure rappresenta una scelta più o meno ponderata, ma certamente indicativa di libertà e desiderio di infrangere i tabù legati al cancro.
Anche oggi, a distanza di quasi diciott’anni da allora, se qualcuno mi dice “tu che hai sconfitto il cancro” dico “no, non l’ho sconfitto. Meglio pensare che le cure hanno funzionato e sono guarita.”
Tutto quello che ho fatto, nei mesi successivi alla diagnosi, è stato affidarmi alla medicina accompagnandola con tutte le strategie più o meno alternative che mi sembravano utili a guarire.
E nessuno mi ha mai detto che il mio cancro e le mie metastasi non fossero curabili.
Ma quando c’è stato il sospetto che oltre al fegato le metastasi avessero attaccato anche una vertebra ero sicura che sarei morta. E per un pomeriggio intero mi sono messa a letto, a piangere, pensando a Lula che era troppo piccola per perdere sua madre.
Anche allora nessuno mi ha detto che non sarei potuta guarire. Anzi, che c’era molto da fare. Ho pure iniziato a fare pratiche di autoguarigione, convinta che la mia testa avesse il potere di sanare quel grumo di mie cellule che avevano svalvolato per qualche ragione che risiedeva dentro di me, nel mio corpo, nella mia anima.
Poi quel sospetto è stato fugato, io ho continuato a fare la pratica, ma le metastasi del fegato erano lì, andavano tolte chirurgicamente. E di nuovo chemio, e terapia ormonale. E insomma, per me le cose sono andate bene, ma ci ho messo anni e anni a sentirmi davvero guarita.
Anna, invece, quando ha visto che le sue metastasi non sparivano, anzi, si riformavano, ha capito che con il cancro, nella migliore delle ipotesi, avrebbe dovuto conviverci, e per un tempo non troppo lungo: “ho ben chiari i confini della mia condizione e sono pronta a esplorarne i limiti ed eventualmente a superarli se la scienza me lo consentirà. Ma non posso fare finta di non aver letto queste statistiche. Questo in qualche modo significa che il pensiero della morte spesso mi è vicino. Non come uno spauracchio, non come un mostro pauroso. Semplicemente ci penso.” (Dal post del 17 febbraio 2011, cit. a p. 38 di Scriverne fa bene)
Anna è morta quasi 10 anni fa, ed è stato inevitabile pensare a lei quando a maggio ho letto l’intervista di Michela Murgia nella quale rivelava di avere un cancro metastatico e quindi una ridotta aspettativa di vita.
Ho iniziato a seguire con commozione la strada che aveva intrapreso, e tante volte avrei voluto contattarla per dirle quanto la comprendessi e considerassi importante che una donna così attiva nel dibattito pubblico avesse deciso di condividere la sua condizione di malata terminale. Non l’ho fatto, e me ne rammarico.
Ho sofferto, come certamente ha sofferto lei, quando leggevo commenti infastiditi, o veri e propri attacchi disgustosi per la libertà con cui lei aveva scelto di vivere e rendere pubblica la fase più delicata e difficile della propria esistenza.
L’hanno accusata di volersi fare pubblicità e di usare la malattia per aumentare le vendite del libro che aveva appena scritto. Che miserabili!
C’è chi ha addirittura messo in discussione il fatto che Michela potesse affermare che il suo cancro, metastatizzato ormai ovunque, non fosse più curabile.
Qualcuno ha considerato questa consapevolezza un “cattivo esempio” per altre persone gravemente malate, invece di leggerla come l’estremo atto di libertà, uno squarcio nel buio che terrorizza.
Altri si sono indignati per la “spettacolarizzazione” di una vicenda così intima, come se ci fosse un solo modo per affrontare il cancro e la fine della propria vita: quello del silenzio, della solitudine e della vergogna, quello del nascondimento dei segni che sembrano spaventare più chi li guarda di chi li porta sul corpo o li esprime con le parole.
Io invece ho trovato confortante vedere i sorrisi luminosi di Michela, i cappelli e i turbanti colorati, gli abiti bianchi del matrimonio contratto per garantire che le proprie scelte fossero rispettate, visto che la sua famiglia queer non aveva lo stesso riconoscimento di quella tradizionale.
È stato un conforto ascoltare e leggere le parole con cui ha spiegato il senso delle sue scelte. Parole, come ho già detto, per me non del tutto nuove. Ma pronunciate da una donna con un profilo pubblico così forte certamente hanno avuto e avranno un impatto rilevante e potranno contribuire a infrangere il muro di pregiudizi e di cattivi giudizi che ancora gravano sul cancro.
E allora grazie ad Anna prima, a Michela poi, per avermi insegnato che si può parlare della propria vita e della propria morte con la stessa, faticosissima, libertà.